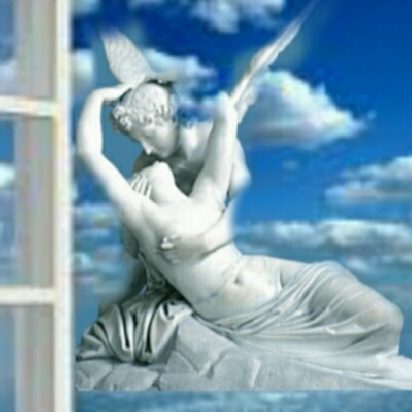Lamentarsi è un atto assai facile, comune e frequente. Chi, per un motivo o per un altro, non si è mai lamentato nel corso della sua esistenza?
A volte, ci lamentiamo per sfogarci, per liberarci di un peso; il farlo assume, per noi, una funzione catartica e ci aiuta a star meglio.
Tuttavia, spesso lo facciamo sin troppo e di fronte a qualsiasi problema.
Ci sono persone, poi, che fanno della lagna un vero e proprio stile di vita, investendo e sprecando tanto tempo ed energia a mugolare e a piagnucolare di continuo; sono quelle che trovano, in ogni situazione, qualcosa che non va e che vedono sempre il bicchiere mezzo vuoto.
La loro visione della vita è negativa e pessimistica.
Per questi individui sono sempre gli altri quelli sbagliati, quelli da criticare e condannare, quelli colpevoli da additare delle proprie disgrazie e della propria infelicità.
Dalla loro prospettiva di giusti, detentori di soli diritti nonché vittime innocenti, tali soggetti guardano al mondo e alla vita senza, tuttavia, mai goderne pienamente, con l’abitudine ben consolidata di lamentarsi di tutto e tutti.
Il reclamo e la protesta diventano una risposta automatica ed istintiva alle difficoltà che incontrano, risposta su cui finiscono per organizzare l’intera loro personalità e tutta la loro esistenza.
Costantemente impegnati in un incessante e rumoroso lamento di sottofondo, queste persone, di frequente, soffrono di disturbi di ansia, depressione ed ossessioni e sono alla ricerca di chi, complice e collusivo a tale loro modo di funzionare, ascolti, avvalori ed accolga, soccorrendoli e spalleggiandoli, il loro perenne lagnarsi.
Le loro relazioni sociali sono improntate sull’egocentrismo (tali individui, con le loro rimostranze, si pongono al centro dell’attenzione di amici, familiari e parenti) ed assumono, quasi sempre, caratteristiche di dipendenza (i soggetti lamentosi si mostrano sempre bisognosi di qualcosa e/o qualcuno e sono altamente richiestivi e pretestuosi nei confronti degli altri).
Nei rapporti interpersonali la lamentela è usata come forma di manipolazione che tende a colpevolizzare l’altro e deresponsabilizzare se stessi. C’è, sovente, un sottile e subdolo piacere sadico nel lagnarsi e nel frignare, una forma nascosta ed ambigua di aggressività passiva verso l’altro.
Il continuo lamentarsi assume, per le persone in questione, la funzione di difesa e rafforzamento di un Io debole, fragile e carente. Si tratta, tuttavia, di un processo che si rivela, illusorio, inefficace ed altamente disfunzionale e controproducente.
Attraverso la lamentela gli individui finiscono per adagiarsi nella loro posizione di vittime e per trarne i loro vantaggi e benefici senza mai avvertire il bisogno di cambiamento e di attivarsi per una soluzione.
Il loro atteggiamento, determinato da un locus of control esterno che attribuisce la causalità di tutto quel che succede all’esterno, tende ad essere passivo, dipendente ed immaturo.
L’impatto sulla loro vita sociale è notevole: gli altri, esausti e stanchi, tendono, con il tempo, ad allontarsi e a rifiutarli.
La scienza ha dimostrato che essere esposti ripetutamente alla lamentela è fonte di stress e produce danni effettivi a livello cerebrale.
Il nostro cervello tende ad interpretare la lamentela come una minaccia e a preparare l’organismo per l’emergenza. L’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, con il conseguente aumento di secrezione del cortisolo, ci allerta e ci predispone, di fronte alla percezione di pericolo, ad una risposta di attacco o fuga che di fatto, però, non avviene. Si assiste, in tali condizioni, alla morte dei neuroni con interruzione di importanti connessioni neurali nelle aree cerebrali, deputate all’attività di risoluzione dei problemi e alla memoria, della corteccia prefrontale e dell’ippocampo e alla riduzione significativa di quest’ultimo.
La lamentela è, perlopiù, contagiosa: i neuroni specchio ci portano ad empatizzare con la prospettiva del nostro interlocutore e a condividerne emozioni e stati d’animo. In altre parole, di fronte alle lagne continue degli altri, il rischio non è solo quello di stressarci ma anche quello di finire noi stessi per essere più piagnucolosi.
L’ascolto reiterato di lamentele e la tendenza a lamentarsi portano, infine, inevitabilmente ad un pericoloso automatismo con conseguente condizionamento negativo di se stessi. Il lamentoso finisce intrappolato nella rete della sua stessa lamentela all’interno di un circolo vizioso pieno di frustrazione e malcontento da cui diventa estremamente difficile uscire.
Più tendiamo a lamentarci, infatti, meno riusciamo a vedere le opportunità, a sfruttare le occasioni e a mobilitare le azioni necessarie per rimuovere le cause della nostra insoddisfazione, rimanendone, all’opposto, tristemente prigionieri.
Se qualcosa non va o non ci piace, diamoci da fare per cambiarla o per trovare una soluzione. Quando gli avvenimenti e il mondo fuori non si prestano a essere modificati, attiviamo risorse e capacità per cambiare e migliorare noi stessi.
Mettendoci in discussione ed assumendoci la giusta dose di responsabilità, riusciremo ad essere più appagati e felici della nostra vita.
Dott.ssa Cinzia Cefalo