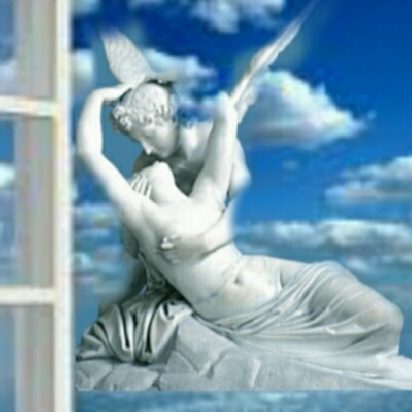È solo passando per questa tappa così complicata e difficile della nostra vita che giungiamo alla formazione di una personalità adulta autonoma ed indipendente.
Si tratta sicuramente di un cammino lungo ed arduo, non del tutto indolore e privo di ostacoli, basato sostanzialmente sul processo di separazione psicologica dalle figure di accudimento.
Si parla, infatti, di una vera e propria crisi evolutiva di identità dove i traguardi fino ad allora raggiunti in termini di acquisizioni ed apprendimenti di capacità ed abilità sono messi in discussione al fine di nuove e diverse scelte e decisioni (come il termine crisi, dal greco Krisis = scelta, decisione, vuole significare).
Ciò non significa naturalmente una cancellazione e vanificazione delle precedenti esperienze infantili, pilastri fondamentali, al contrario, dello sviluppo psicologico dell’individuo, ma un loro momentaneo ‘obnubilamento’ e sconvolgimento allo scopo di un, per così dire, ‘tirare le somme’ finale.
È un po’ come mettere sul piatto della bilancia tutto e il contrario di tutto o tirare fuori tutto ciò che abbiamo in frigo nel tentativo di decidere quale piatto cucinare. Il risultato è indubbiamente un momentaneo stato di caos e confusione finalizzato, tuttavia, alla ricerca di qualcosa di più stabile, certo e sicuro, la nostra identità.
Non che, poi, il percorso finisca qui: il processo di costruzione della nostra identità dura in realtà tutta la vita ma è a partire dall’adolescenza che inizia a basarsi su esperienze ed azioni frutto di scelte più consapevoli ed intenzionali da parte del soggetto.
Oggi, nella nostra società, fattori politici, economici e culturali, come ad esempio il prolungarsi degli studi, la difficoltà a trovare un lavoro e/o un alloggio, ecc., non facilitano il passaggio all’età adulta e, al contrario, favoriscono il permanere nella condizione ambigua ed indefinita dell’adolescenza, nella quale non si è più bambini ma neanche completamente adulti dal punto di vista dell’autonomia e dell’indipendenza, non solo materiale ma anche, e spesso soprattutto, affettiva.
Accanto a tali fattori, spesso altre condizioni rendono più tortuoso ed intricato, nonché più doloroso, il percorso evolutivo degli adolescenti: alcune di esse derivano, purtroppo, proprio dalla famiglia stessa.
Si tratta di ragazzi non aiutati e/o sostenuti dai genitori nel loro cammino di individuazione ma, al contrario, ostacolati, in vari modi, nel loro percorso di crescita.
Spesso figli unici o primogeniti, a lungo desiderati, realizzazione dell’ego dei genitori e non solo (a volte ci si mettono pure nonni e zii), questi adolescenti non possono permettersi di deludere le elevate aspettative che le figure di riferimento nutrono nei loro confronti e finiscono per aderire alle loro richieste, sviluppando un falso sé compiacente.
Considerati ‘speciali’ (troppo bravi o troppo belli), esaltati, adulati ed adorati, rispecchiamento narcisistico, in realtà, solo delle aspirazioni e dei desideri dei loro genitori, diventano precocemente adulti iper-responsabili, bravi a scuola e perfetti in ogni cosa.
Si trovano, tuttavia, a pagare in termini di spontaneità ed autenticità, autonomia ed individualità il prezzo del privilegio dell’essere i primi (primi figli, primi nipoti) ed i migliori (a scuola, nello sport, ecc.), sobbarcati dal peso di una responsabilità non richiesta e della quale non riescono facilmente a liberarsi.
Non si sentono in grado di decidere per se stessi senza percepire di star tradendo in qualche modo i loro genitori, rimanendo in tal modo dipendenti da essi ed incapaci di svincolarsi.
In questi casi, il bisogno di non deludere si dimostra maggiore di quello di crescere; anche perché la scelta alternativa, quella, cioè, di comportarsi diversamente da quanto atteso dagli altri, significherebbe confermare a questi ultimi, nonché a se stessi, di non essere all’altezza di ciò che si pensa di loro e, di conseguenza, avrebbe un significato squalificante e svalutante per l’autostima personale.
Capita, allora, che l’unico modo per uscirne, ma solo in casi estremi quando l’individuo proprio non ce la fa più, può essere il black out totale, un vero e proprio blocco sul piano emotivo, cognitivo e comportamentale. Si tratta di una vera e propria paralisi, espressione, non solo del timore e della difficoltà ad andare avanti, ma soprattutto del rifiuto, più o meno intenzionale e consapevole, di una condizione vissuta dall’adolescente come estremamente insopportabile ed altamente fagocitante.
Questa scelta, paradossalmente e ricorsivamente, rende il soggetto, ancora una volta e ancora di più, dipendente dalle figure di accudimento.
Il tentativo, spesso totalmente inconscio, di opposizione è destinato, infatti, a fallire: le azioni dell’individuo non appaiono affatto frutto di una presa di coscienza e di posizione derivante da scelte autonome ed indipendenti, magari sostenute ed incoraggiate dall’esterno, ma rappresentative, al contrario, di un inconsapevole gesto estremo di ribellione, reattivo e dipendente dall’urgenza emotivo – affettiva dettata dalle condizioni ambientali.
Inoltre, l’atteggiamento dell’adolescente viene interpretato dai genitori come sua difficoltà ed incapacità personale e, di conseguenza, come bisogno di un intervento decisionale, e non solo, da parte loro in un momento di crisi del figlio.
L’adolescente è così in trappola, incastrato in un meccanismo dal quale è arduo uscire. In tale contesto muoversi autonomamente è praticamente impossibile, specie quando le scelte contrastano con quelle dei genitori, perché il rischio è deludere loro e se stessi con tutto ciò che questo, come sopra detto, comporta.
Dott.ssa Cinzia Cefalo